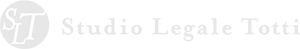La sottile linea che passa dalle strategie di business dei grandi laboratori di consulenza aziendale al suicidio di massa nelle fabbriche cinesi.
Il nuovo supporto tecnologico che ci permette la sempre più agognata e “necessitata” voglia di connessione costante e globale è elegante, comodo e, contrariamente da quanto sostenuto dagli immancabili detrattori del “pre-market”, efficace.
L”I-pad” è, come dicono gli americani ,“sleek”. La miglior traduzione ad literam che possa travasare nelle nostre categorie il termine anglosassone è “fico”.
I fogli di giornale brillano e scorrono agili sul display portatile che attira gli sguardi invidiosi degli sconosciuti compagni di viaggio alle file dei check-in negli aeroporti.
Tecnologia e status trovano una delle espressioni simbiotiche più perfette che siano mai state offerte dal mercato. L’holder della tavoletta si trova subito proiettato in quell’avant-garde che segna il distinguo, non tanto e non più tra il mero utilizzatore delle ultime innovazioni ma, invero, tra chi vive e chi non vive nelle highways della bit-information.
Eppure il nuovo “device” (da noi aggeggio) è informativo e comunicativo non solo per quello che ci fa leggere, vedere e ascoltare ma lo è anche in quanto portatore di una sua propria storia che, sebbene recentissima, è importantissima ed indicativa per le luci ( o le ombre a seconda dei punti di vista ) che proietta sul futuro prossimo dell’economia mondiale.
La clausola di “divieto di suicidio” che il produttore cinese Foxconn, che realizza appunto tra tantissimi altri prodotti anche l’ultimo nato di casa Apple, impone ai propri dipendenti per fermare il “disagio” interno (così come l’obbligo di comunicare immediatamente i dubbi che dovessero sorgere al lavoratore circa la preferibilità ad una via terrena con un lavoro sicuro con turni da 18 ore al giorno verso le incertezze di una vita ultraterrena priva di qualsiasi garanzia contrattuale) non è il frutto “peregrino” e casuale di un produttore cinese ma è invece il risultato prevedibile, quasi logico, di un assetto e di una strategia economica che passa sotto il nome, tecnico e dal bel suono, di CHINA PLUS ONE.
Uno studio di mercato realizzato, già nel 2006, da una delle più prestigiose aziende di consulenza strategica aveva reso ben chiaro ai grandi produttori dei paesi industrializzati come fosse assolutamente vitale porre in essere delle strategie di diversificazione produttiva in tutto il territorio asiatico.
Produrre in Cina si; ma bisogna avere pronto un piano B in caso di problemi in quanto la Cina non sarà più in grado di garantire ritmi e costi di lavoro cosi bassi.
Tra i rischi maggiori, intravisti appunto già quattro anni fa, al primo posto campeggiava quello dell’ “insostenibilità sociale” del modello di sviluppo cinese basato quasi esclusivamente sul vantaggio competitivo della manodopera a basso prezzo.
Già allora la nota azienda di consulenza rilevava che gli 87.000 casi di rivolte e disordini in fabbrica (chi ne aveva mai sentito parlare da noi..?) verificatesi l’anno prima, nel 2005 dunque, non potevano considerarsi un fenomeno contingente ma erano da qualificare come strutturali.
La prima ripercussione negativa in termine di business sarebbe stata l’inevitabile istanza generalizzata di aumento salariale che, cosi già premonivano gli esperti, non sarebbe stata gestibile, se non per un periodo limitato, dagli organi centrali del Partito Comunista che avrebbero dovuto garantire una valida azione di contrasto alla spirale “wage-increase-infltation-currency appreciation”, ovvero la terribile catena di aumento salariale, pressioni inflazionistiche, apprezzamento della moneta.
Imperativo dunque iniziare a dislocare e creare alternative alla Cina anche per poter realizzare, in caso di necessità, comodi arbitraggi di produzione.
Così a fronte delle misure anti-dumping imposte dal governo americano sulle scarpe di importazione cinese , nel 2004 il più grande sub fornitore di Nike ha prontamente azionato gli stabilimenti in Bangladesh.
Quanto gli analisti ci avessero visto giusto è dimostrato dall’aumento salariale del 50% che Honda si è, oggi, vista costretta a riconoscere alla sue maestranze.
Ma se gli analisti “vedono lungo” altrettanto chiara è la visione del Partito Comunista cinese che, per quanto tenga il piede schiacciato sul freno dell’aumento salariale e dell’apprezzamento della moneta, è ben consapevole che una crescita del PIL all’8% annuo, la soglia minima richiesta per il mantenimento del sistema ai ritmi raggiunti negli ultimi dieci anni, non potrà essere mantenuta né con stimoli fittizi, come quello che ha portato alla costruzione una intera città da un milione di abitanti ad oggi ancora assolutamente deserta (la città di Ordos nella Mongolia centrale offre uno scenario surrealista alla Philip Dick ), né tanto meno su un modello economico “labour-intensive”, ovvero fondato sullo “sfruttamento”.
Dimostrazione ne è il fortissimo lavoro di investimento sulle infrastrutture sia interne che esterne al fine di collegare la Cina, fino alle sue zone centrali, con tutti i nuovi hubs dell’economia asiatica e lo sforzo politico concertato che dovrà culminare nel 2015 con la creazione dell’ASEAN Economic Community.
Altro indicatore chiave dell’inizio del cambiamento è la sempre maggior attenzione che viene riservata alla tutela della proprietà intellettuale, anche se la tutela scatta solo quando si tratta di proteggere gli investimenti cinesi…, nonché le misure di incentivazione economica e fiscale che vengono in misura sempre maggiore riservati alle attività di ricerca e sviluppo.
Che impatto ha, ed avrà, questo sul patrio suolo? In Italia non si potranno certo calmierare i rischi inflazionistici con clausole alla “cinese” né tanto meno sperare in un aumento della produttività che faccia leva sulla riduzione dei costi della forza lavoro; Pomegliano insegna.
I cinesi non hanno ancora cambiato rotta ma stanno già decisamente cambiando strada.
Lo faremo anche noi italiani investendo sull’innovazione comprendendo che la ricchezza industriale non è più fondata sui “capannoni” sempre più deserti del nord-est, ma sul numero di brevetti registrati e contabilmente ben allocati e valorizzati nel patrimonio delle nostre società ; altrimenti non potremo che aspettare di diventare noi i “cinesi del lusso” dispensatori di poche e specializzate maestranze artigianali che lavoreranno per un marchio ex-italiano di proprietà di un gruppo multinazionale con la Holding Company a Singapore.
I casi dell’industria tessile di Prato e, giusto per rimanere in zona, il marchio Panerai che ha rivisto gli splendori solo dopo l’acquisizione di LVMH, dovrebbero farci riflettere sull’importanza dei temi e sulla velocità con la quale i cambiamenti strutturali delle logiche della produzione e distribuzione dettati dalla globalizzazione prendono piede.
Non è più tempo di riflettere ma di agire.
Scritto da Avv. Marco Gianni